Arrivare almeno mezz’ora prima dell’orario scritto sul
foglio, radunarsi alla spicciolata intorno alle teste di capelli cui si vuole
più bene e a fianco delle quali si son trascorse più ore di studio e sudate più
gocce di sudore, fare la pipì, a volte anche la cacca, aspettando il proprio
turno come se fosse l’ultima cosa da fare prima della fine del mondo, dividersi
per lettera, separarsi dal Ziosi o dallo Zama di turno che appartengono a
gruppi alfabetici troppo lontani dal tuo, gestire mal di pancia, inopportuni squilli
di cellulare, vocabolari, cibarie e fogli protocolli tutti con le stesse due
mani e lo stesso cuore spaventato e forte, sedersi in aule dove un tempo tutto
era spianato facile di fronte a te, e poi – soprattutto – riempire di cazzate e
risa convulse quegli ultimi istanti che separano dal tuffo nel compito, basta
che siano cazzate o risa convulse, e non importa per cosa o su cosa, conta solo
riempire e riempire quei minuti, qualunque banalità per non sentire quel
dannato tremito alle mani.
Ci sono prove che
sono prove in tutti i sensi. Prove di
verifica, prove di forza, prove di vita.
Ma se la verifica la si può superare, se la sufficienza matematica si ottiene –
nonostante tutto, anche stavolta ce l’abbiamo fatta – se la forza scavando tra
date e paradigmi alla fine la tiri fuori e la penna la impugni e scrivi tutto
ciò che c’è da scrivere senza svenire nemmeno per un secondo, se tutto questo
funziona e passa lasciando anche una leggera sensazione di spossato trionfo, la
prova di vita, boh, secondo me quella
ti arriva in faccia e fa solo male e non puoi farci nulla.
La prova di vita
che comporta un concorso come quello che stiamo vivendo in tanti, in Italia,
ora – nel silenzio di telecamere e urla sindacali – ti arriva in faccia e fa
male e basta. Punto. Non la si supera né la si vince. E te ne accorgi, come
spesso accade con la sofferenza, prima da quelle degli altri, di ferite, che
dalle tue. La vedi spalmata in faccia sulle occhiaie della tua più cara amica,
la vedi nelle lacrime della compagna coriacea che ha superato ogni esame come
una passeggiata, la vedi nei toni impercettibilmente
e drammaticamente più alti delle
voci degli amici, all’uscita dal compito, la vedi anche nell’apatia del ragazzo
che mai si emoziona, mai si agita, ma al contrario degli altri si asciuga inesorabilmente perdendo lo
sguardo oltre il fumo dell’ennesima sigaretta. Concorsi grandi e baracconi
esaminatori come questo ti valutano, ti innalzano, ti qualificano, forse, ma a
che prezzo.
Il prezzo da pagare è quello di sentirsi scivolare via la
pelle della dignità – quella superficiale, certo, ma pelle era e pelle resta –
mano a mano che la fila dei candidati si assottiglia ed arriva il tuo turno per
il riconoscimento con la carta di identità; il prezzo da pagare è
quell’indolenzimento alla mano al termine del secondo foglio protocollo di
compito che è in realtà un indolenzimento della parte più bella del tuo cervello; ed è un prezzo che non si paga tanto in
litri di sudore o di lacrime, secondo me, quanto piuttosto in decimetri di schiene che si accorciano e
si attorcigliano su loro stesse.
Arrivi alla fine – o anche solo a buon punto, come si trova Tinni in questo istante – che quello che
ti stanno raschiando via con una lima piccola ma affilata non è né il tempo –
il tempo dello studio, il tempo dell’attesa, il tempo dell’esame – e non è
neppure l’allegria – ché il sorriso che basta per mangiare qualcosa insieme, o
per bere una birra alla faccia del tieffeadimmerda, quello lo si trova sempre –
ma è il tuo nome.
Il tuo nome, è
quello che lentamente svanisce affievolendosi tra le urla stanche e
professorali degli appelli antelucani ed i codici di riconoscimento numerico; è
il nome, è il nocciolo della te più intima che password ed elenchi telematici
si ostinano a spingere sott’acqua fino a fargli quasi mancare ogni forza.
E così, ad una settimana dallo scritto del tfa, stamattina mi sentivo piena di
elogi, di voti, di complimenti, di congiuntivi indipendenti e di stilemi
tucididei, ma vuota di me. Non mi
ricordavo più la strada di casa, né il numero di telefono fisso, e stentavo a
riportare alla mente persino la sfumatura del mio colore preferito.
E poi – per fortuna ché altrimenti non sarei qui a battere
sui tasti per voi ancora una volta – e poi è successo che sono passata da casa
dei miei, stamattina, e ne sono anche uscita, e mentre mi avviavo anonima alla macchina ho incontrato
Giuseppe.
E qui bisogna fare un piccolo passo indietro – portate
pazienza – ché occorre che vi spieghi chi è Giuseppe e che parte occupa nella
mia vita. Giuseppe non occupa alcuna parte importante nella mia vita, in
realtà, se non il fatto che è il vicino di casa dei miei genitori e fino a
pochi mesi fa anche il mio. Non occupa nessuna parte di rilievo se non quella
di essere un uomo ultraottantenne che è stato – ed è ancora – nonno di un mio coetaneo
con cui ho giocato per qualche brandello di estate infantile; se non quella di
essere un uomo tristemente e coraggiosamente vecchio, con pochi denti e ancor meno ricordi, il passo incerto e
lo sguardo perso oltre una campagna dove gli acciacchi non gli permettono più
di lavorare. E da quando Giuseppe non c’è più moltissimo con la testa succede ormai costantemente che, ogni volta che mi incontra, si aggrappa al mio
braccio e all’unico ricordo – sempre lo stesso – che quel braccio gli solletica
e gli guadagna e mi dice ciao Soffia ti
ricordi che Luca ti chiamava così quando eravate piccoli, no?
E davvero vorrei che tutti voi aveste anche solo una vaga
idea del numero abnorme di volte che
ho sentito questa frase e delle occasioni in cui ho imposto un sorriso al mio
broncio al suono sputacchiato di quelle due effe
di troppo. Del numero di volte in cui Giuseppe mi ha fatto fare ritardo – col
suo modo lento e zoppicante di parlare, oltre che di camminare – con questo
saluto e questo ricordo – sempre lo stesso – e di quante volte io abbia cercato
di sottrarmi a tale patetico rito rievocativo ed onomastico.
Ecco, se ora ne avete anche solo una lontana e vaga idea,
allora posso continuare nella mia storia di ieri, riprendendo da dove mi ero
interrotta, per dirvi che, invece, ieri, no,
non mi sono sottratta al rito onomastico e rievocativo – già lo sapevo, quando
scendendo dal viale ho visto lui e la moglie avvicinarsi al mio marciapiede,
che saremmo andati a finire lì - e mi
sono lasciata – anonima e spellata – prendere il braccio da Giuseppe pensando
che non c’era null’altro da fare, ormai, se non entrare a testa bassa sul palco
e recitare quella logora parte, ancora una volta.
Solo che non avevo considerato una cosa: non avevo
considerato – e ci riflettevo pochi minuti dopo, toccando a tentoni un sorriso
che sembrava affondato insieme agli schemi di storia greca e ai moduli risposte
dei test a crocette, in macchina, mentre il vento forte fuori dal finestrino
cantava la breve vittoria di un nuovo inizio – non avevo considerato che, ieri,
io ero senza nome e senza schiena,
senza numero di telefono fisso e senza il ricordo del mio colore preferito, e
Giuseppe, stringendomi il braccio e dicendomi ciao Soffia, ti ricordi che Luca ti chiamava sempre così quando eravate
piccoli, no, semplicemente, ecco,
me ne ha restituito uno.
Poi, che il nome avesse qualche effe di troppo, ma a me, in fondo, che me ne importa?
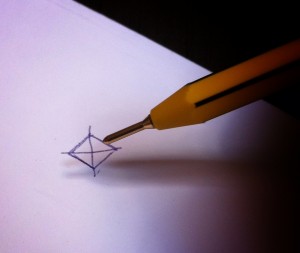
Nessun commento:
Posta un commento